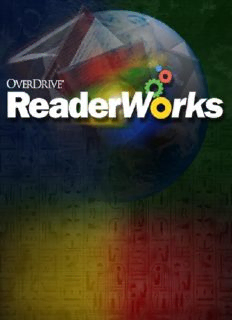
PADDY CLARK AH AH AH PDF
Preview PADDY CLARK AH AH AH
PADDY CLARK AH AH AH! di Roddy Doyle Venivamo giù per la nostra strada. Kevin si fermò a un cancello e col bastone gli mollò un colpo. Era il cancello della signora Quigley; quella stava sempre alla finestra ma non faceva mai niente. “Quigley! ” “Quigley! ” “Quigley Quigley Quigley! ” Liam e Aidan svoltarono per il viottolo di casa loro. Noi non dicemmo una parola; loro neanche. Liam e Aidan non avevano la mamma. La signora O'Connell, così si chiamava era morta. “Sarebbe forte, no?” dissi io. “Sì”, disse Kevin. “Fortissimo.” Parlavamo del fatto di avere la mamma morta. Sinbad, il mio fratellino, attaccò a piangere. Liam era in classe mia a scuola. Un giorno se la fece nei calzoni - la puzza ci venne addosso come la ventata di calore quando apri lo sportello del forno - e il maestro non fece niente. Non gridò mica, né picchiò la bacchetta sulla cattedra e roba simile. Ci disse di metterci a braccia conserte, con la testa giù, e di dormire; obbedimmo e lui portò Liam fuori di classe. Passò un sacco di tempo prima che il maestro tornasse, e Liam non tornò per nulla. James O'Keefe bisbigliò: “Se me la facessi io la cacca addosso, mi ammazzerebbe di botte”. “Già.” “Però non è mica giusto”, disse James O'Keefe. “No.” Il maestro, il signor Hennessey, odiava James O'Keefe. Si metteva a scrivere qualcosa sulla lavagna dandoci la schiena e diceva: “O'Keefe, lo so che stai tramando qualcosa laggiù. Bada che non ti pizzichi”. Lo disse un mattino che James O'Keefe nemmeno era in classe. Stava a casa con gli orecchioni. Henno portò Liam nel gabinetto degli insegnanti, lo ripulì; poi lo portò nell'ufficio del direttore, e quello lo portò dalla zia, in macchina, perché a casa sua non c'era nessuno. La casa della zia di Liam era a Raheny. “Ha fatto fuori due rotoli di carta igienica, ci raccontò Liam. “E poi mi ha dato uno scellino.” “Ma va'... Faccelo vedere!” “To'.” “Questi sono solo tre penny.” “Il resto l'ho speso.” Liam tirò fuori di tasca quel che avanzava dí un pacchetto di mou e ce lo mostrò. “Visto?” “Beh, non offri?” “Me ne sono rimaste solo quattro”, disse, ricacciandosi il pacchetto in tasca. “Ah”, disse Kevin, e diede uno spintone a Liam. Liam se ne andò a casa. Questo giorno qui, stavamo tornando a casa dal cantiere. Avevamo preso un sacco di chiodi da sei pollici e qualche pezzo di tavola per fare una zattera, poi ci eravamo messi a spingere mattoni in un fossetto pieno di cemento fresco, quando Aidan era schizzato via di corsa. Sentivamo il suo fiato grosso, e ci mettemmo a correre anche noi, convinti che ci avessero beccati. A me mi toccò aspettare Sinbad. Così mi voltai a guardare e vidi che nessuno ci inseguiva, però non fiatai. Presi Sinbad per mano e corsi a raggiungere gli altri. Ci fermammo solo quando fummo fuori dei campi, lì dove finiva la strada, e ci mettemmo a ridere. Ridevamo a crepapelle, davanti al varco nella siepe. Poi ci infilammo dentro, guardando bene che non arrivasse nessuno. La manica di Sinbad si impigliò negli spini. “Eccoli!” urlò Kevin, e scivolò dall'altra parte. Lasciammo Sinbad incagliato fra i rovi e facemmo finta di svignarcela. Frignava, lui, lo sentivamo. Ci acquattammo dietro i pilastri del cancello dell'ultima casa prima che la strada finisse davanti alla siepe; era quella dove abitavano gli O'Driscoll. “Patrick...” piagnucolava Sinbad. “Sin-baad...” gridò Kevin. Aidan si mordeva le nocche per non ridere. Liam gettò un sasso contro la siepe. “Lo dico a mamma”, disse Sinbad. Alla fine io cedetti. Andai a tirarlo fuori dalla siepe e lasciai che si pulisse il naso contro la mia manica. Dovevamo andare a casa, noi, era ora di cena. Martedì pasticcio di carne. Il padre di Liam e Aidan ululava alla luna. A notte fonda, nel giardinetto dietro casa; non tutte le notti, solo ogni tanto. Io non l'avevo mai sentito, ma Kevin diceva che lui l'aveva sentito, eccome se l'aveva sentito. Mamma disse che lo faceva perché sentiva la mancanza della moglie. “La signora O'Connell?” “Certo.” Papà era anche lui della stessa idea. “È triste”, disse mamma. “Pover'uomo.” Il padre di Kevin, invece, diceva che il signor O'Connell ululava perché era ubriaco. Però non lo chiamava mai signor O'Connell; lo chiamava il Barbone. “Guarda da che pulpito”, fece mamma quando glielo raccontai. E poi: “Non dargli retta, Patrick; ti pigliano in giro. Sicuro, e poi dove vuoi che vada a ubriacarsi? Non ci sono mica pub a Barrytown”. “A Raheny ce ne sono tre”, dissi. “Oh, ma Raheny non è certo girato l'angolo”, ribatté mamma. “Povero signor O'Connell. Non voglio sentire altre chiacchiere sul suo conto.” Una volta Kevin disse a Liam di aver visto suo padre, con gli occhi fissi alla luna, ululare tale e quale un lupo mannaro. Liam gli rispose che era un bugiardo. Kevin lo sfidò a ripeterlo, se aveva il coraggio. Liam stette zitto. La cena non era ancora pronta e Sinbad aveva lasciato una scarpa giù al cantiere. Ci avevano proibito di andare a giocare da quelle parti, così Sinbad disse a mamma che non sapeva proprio dove fosse finita la sua scarpa. Mamma lo picchiò sulle gambe, dietro. Lo teneva per un braccio, ma lui sgambettava, per cui lei non riusciva a suonargliele a dovere. Continuava a piangere, però, e a un certo punto lei smise. Sinbad era un gran piagnone. “Mi costi una fortuna, mi costi”, gli disse. Anche mamma sembrava lì lì per piangere. Disse che dopo cena avremmo dovuto uscire a cercare la scarpa, tutti e due, perché anch'io avrei dovuto avere più cura di mio fratello. Così ci sarebbe toccato uscire col buio, e infilarci nel varco, attraversare i campi, affrontare la fanghiglia e gli scavi e i guardiani. Mamma ci spedì a lavarci le mani. Chiusi la porta del bagno e, sì, questa volta Sinbad ebbe il fatto suo, gli feci uno stivaletto malese. Poi mi toccò dare un'occhiata a Deirdre, che era in carrozzina, mentre mamma infilava i calzini puliti a Sinbad. Gli asciugò il naso e lo guardò negli occhi per un sacco di tempo, e intanto con le nocche gli asciugava le lacrime. “Su, adesso basta, da bravo...” Avevo paura che gli domandasse perché piangeva ancora, e che lui glielo dicesse. E facevo dondolare la carrozzina proprio come di solito la faceva dondolare mamma. Accendevamo fuochi. Ne accendevamo in continuazione. Mi tolsi il golf perché poi non sapesse di fumo. Faceva freddo adesso, ma chi se ne fregava? Cercai un punto pulito dove metterlo. Eravamo al cantiere e ogni volta trovavamo dei cambiamenti. Questo nella zona recintata dove c'erano le scavatrici e i mattoni, e una baracca dove gli operai andavano a bere il tè. Davanti alla porta c'era sempre un mucchio di croste di pane, grosse croste tutte macchiate di marmellata ai bordi. Ci fermammo al di là dalla rete metallica a guardare un gabbiano che cercava di raccoglierne una, ma era troppo lunga per il suo becco; avrebbe dovuto afferrarla nel mezzo. Poi, a un certo punto, un'altra crosta di pane volò fuori dalla porta e centrò il gabbiano proprio sulla testa, e si sentirono gli uomini nella baracca che sghignazzavano. Arrivammo fino in fondo al cantiere e non c'era più niente solo uno spiazzo quadrato di fanghiglia e mattoni rotti e solchi lasciati dalle gomme. L'ultima volta che eravamo stati qua avevamo trovato il cemento fresco, e adesso invece c'era una strada e il nuovo cantiere era in fondo alla strada. Andammo a vedere dove avevamo scritto i nostri nomi nel cemento. Li avevamo incisi con dei bastoni ma loro li avevano spianati; non c'erano più. “Oh, cacca”, disse Kevin. I nostri nomi li trovavi dappertutto, a Barrytown. Dovevamo farlo la sera, quando gli operai se ne andavano tutti a casa, e in giro restavano solo i guardiani. Se ne accorgevano il mattino dopo, e ormai era troppo tardi: il cemento si era indurito. Scrivevamo giusto i nomi di battesimo, però, non si sa mai che gli saltasse il ticchio di andare di casa in casa, su e giù per tutta Barrytown Road, a cercare quei disgraziati che avevano scritto i loro nomi nel cemento fresco. Non c'era un solo cantiere; ce n'erano un sacco, di cantieri, venivano su case di tutti i tipi. Scrivemmo il nome e l'indirizzo di Liam, col pennarello nero, sulla parete appena intonacata di una delle case in costruzione, e non successe niente. Una volta mamma si accorse che puzzavo di fumo. Prima cosa notò le mani. Me ne acciuffò una. “Guarda che mani! ” disse. “Che unghie! Santo cielo, Patrick, sei a lutto per il gatto?” Poi mi annusò. “Cosa hai combinato?” “Ho dovuto spegnere un fuoco.” Lei mi ammazzò di botte. E il peggio fu aspettare per vedere se lo diceva a papà, quando rincasava. Kevin aveva gli svedesi, marca Swan. Mi piacevano tantissimo quelle scatoline col cigno sopra. Costruimmo una specie di capannuccia con tavole e stecchi, e portammo anche due scatole di cartone vuote, che avevamo trovato dietro i negozi. Le scatole, dopo averle disfatte, le sistemammo sotto la catasta. Il legno da solo ci metteva troppo a prendere. Era ancora giorno. Kevin accese un fiammifero. Io e Liam, di vedetta. Eravamo solo noi tre. Aidan era a casa di sua zia, e Sinbad stava in ospedale perché gli dovevano togliere le tonsille. Kevin mise il fiammifero sotto il cartone, aspettò che pigliasse fuoco e lasciò andare il legnetto. Guardammo le fiamme divorare il cartone. Poi corremmo a nasconderci. Io con gli svedesi ero una schiappa. Mi si spezzava sempre il fiammifero, o non si accendeva, o lo sfregavo contro il lato sbagliato della scatolina; o, se si accendeva, ero io che lo lasciavo andare troppo in fretta. Andammo a ripararci dietro una delle case in costruzione. Appena arrivava il guardiano, ce la filavamo. La siepe era la nostra via di fuga, e non era lontana. Kevin aveva una teoria: non potevano farci niente, diceva, a meno che non ci pizzicassero dentro nel cantiere. Se ci acchiappavano fuori, per strada, e magari ci davano un fracco di botte, noi li potevamo anche denunciare, se volevamo. Da dove eravamo, il fuoco non lo vedevamo bene, ma restammo lì ad aspettare. La casa dietro cui stavamo nascosti apparteneva a una fila di sei villette, però non era ancora una vera casa, in piedi c'erano solo due o tre pareti. Tutte queste case qui le costruiva la Spa. Aspettammo un altro po', e io mi accorsi che avevo dimenticato il golf. “Uhh! ” “Che ti piglia?” · “Uhh...cavolo! ” “Che hai?” “Allarme, allarme!” Strisciammo lungo il fianco della casa; ma non per tutto il percorso, però, perché ci sarebbe voluto troppo tempo. Vicino a dove avevo messo il golf, c'era un barile. Sgattaiolai fino dietro il barile, mi accucciai, e presi un gran respiro prima di scattare. Mi voltai verso gli altri; Kevin si drizzò in piedi, si guardò attorno e si riaccoccolò. “Via libera”, sibilò. Inspirai a fondo e uscii allo scoperto gettandomi, sul golf. Nessuno gridò. Io feci il rumore come di una bomba, e brancai il golf che stava su una pila di mattoni. Poi mi infilai di nuovo dietro il barile. Il fuoco aveva preso bene, c'era un sacco di fumo. Raccolsi un sasso e lo gettai nelle fiamme. Kevin si raddrizzò di nuovo, non c'erano guardiani in vista e mi fece segno di raggiungerlo. Io, sgattaiolando, raggiunsi di nuovo la casa in costruzione. Kevin mi diede una pacca sulla spalla. Liam, uguale. Mi legai il golf attorno alla vita. Con le maniche feci un doppio nodo. “Forza, uomini.” Kevin abbandonò il riparo mettendosi a correre; noi gli andammo dietro e cominciammo a saltellare attorno al fuoco. “Uuuh uuuh uuuh uuuh uuuh” Gridavamo mettendoci la mano sulla bocca, come gli indiani. “Uuuuh uuuh uuuh uuuh” Kevin mi si voltò contro e diede un calcio nel fuoco, ma non mi prese; la catasta si afflosciò e basta. Come falò non era più un granché. Smisi di saltellare. E anche Kevin e Liam. Kevin acchiappò Liam e lo spinse verso le fiamme. “Giù!” Diedi una mano a Kevin, ma Liam si fece serio serio, così la smettemmo. Si sudava da crepare. Io ebbi un'idea. “Il guardiano è sceee-mooo!” Corremmo di nuovo dietro la casa in costruzione, ridendo. Poi, in coro: “Il guardiano è sceee-mooo, sceee-mooo, sceee-mooo!” Ci sembrò di udire un rumore; fu Kevin a sentirlo. Allora filammo a precipizio verso la siepe. Io andavo avanti a zigzag, correndo a testa bassa, così nessuna pallottola poteva beccarmi. Mi tuffai attraverso il varco nella siepe, cadendo giù nel fosso. A quel punto ci fu una specie di zuffa, ma più che altro a spintoni. Liam mi tirò un pugno alla spalla, ma mi colpì sull'orecchio facendomi un male cane; per cui dovette lasciare che gli restituissi il favore, mollandogli a mia volta un colpo sull'orecchio. Si mise le mani in tasca, così non avrebbe cercato di fermarmi. Alla fine uscimmo dal fosso, stufi dei moscerini che ci finivano in faccia. Sinbad non voleva saperne, di mettersi in bocca la benzina dell'accendino. “È olio di halibut”, gli dissi. “Non è vero, non ci credo.” Si dimenò, ma io lo tenni fermo. Stavamo nel cortile di scuola, nel capanno. A me l'olio di halibut piaceva. Mi piaceva quando rompi la plastica coi denti, e l'olio ti si spande tutto in bocca, come l'inchiostro sulla carta assorbente. Era un gusto caldo; mi piaceva. E anche la plastica aveva un buon sapore. Era lunedì; quel giorno toccava a Henno sorvegliarci quando uscivamo in cortile, lui però si piazzava sempre nel punto più lontano, e restava imbambolato a guardare chiunque giocasse a palla a muro. Che matto! Se fosse venuto dalla parte nostra, al capanno, sai quanti ne avrebbe pizzicati? Se un maestro beccava cinque ragazzi a fumare, a fare confusione e roba simile, con lo stipendio del mese dopo riceveva una bella gratifica; ce lo aveva detto Fluke Cassidy, e suo zio era un prof. Henno invece aveva occhi solo per la palla a muro, e certe volte si toglieva la giacca e il golf e si metteva a giocare. Oh, era un campione. Batteva lui, e la palla non la vedevi finché non colpiva il muro; era come una pallottola. Sulla macchina aveva un adesivo: Chi gioca a palla a muro campa cent'anni. Sembrava che non avesse più labbra, Sinbad, tanto forte le stringeva; non c'era verso di fargli aprire la bocca. Kevin spinse forte il flaconcino di benzina, ma non riuscì a ficcarglielo dentro. Pizzicai il braccio di Sinbad, e anche questo non servì a niente. Era una cosa terribile; davanti agli altri, non riuscivo a tenere testa a quel moccioso di mio fratello. Allora gli acciuffai una ciocca di capelli, proprio sopra l'orecchio, e tirai, quasi sollevandolo da terra: volevo vedere chi la vinceva. Adesso Sinbad stringeva forte anche gli occhi, ma le lacrime uscivano lo stesso. Gli tappai il naso. Lui boccheggiò e Kevin ne approfittò per ficcargli mezzo flaconcino in bocca. Poi Liam accese un fiammifero. Io e Kevin lasciammo che fosse Liam a dargli fuoco, non si sa mai che ci pizzicassero. Sputò fiamme come un drago. Io preferivo le lenti d'ingrandimento, ai fiammiferi. Passavamo pomeriggi interi a bruciare mucchietti di erba tagliata. Mi piaceva tantissimo osservare come l'erba cambiava colore. Mi piaceva quando la fiamma cominciava a serpeggiare fra gli steli. Una lente d'ingrandimento ti dava più possibilità di controllo. Era un sistema più semplice, ma ci voleva più abilità. Se il sole durava abbastanza a lungo, andava bene anche un foglio di carta, non dovevi mica tenerlo in mano, lo mettevi per terra con un sasso per lato, così non volava via. Avevamo inventato anche una gara; dovevi incendiare il foglio, spegnerlo soffiandoci sopra, poi di nuovo incendiarlo, e di nuovo spegnerlo, e così via. Chi finiva per bruciarlo tutto quanto, faceva penitenza: doveva lasciare che l'avversario gli scottasse la mano. Sul foglio disegnavamo la figura di un uomo e lo bruciacchiavamo, facendogli tanti forellini; gli bucavamo le mani e i piedi, come Gesù. Gli disegnavamo i capelli lunghi. Il pisello lo lasciavamo per ultimo. Tracciammo dei sentieri nelle ortiche. Mamma restò lì, vedendomi col montgomery e i guanti, e volle sapere perché in una giornata così calda andassi fuori tutto imbacuccato. “Stiamo ripulendo un terreno dalle ortiche”, le spiegai. Erano ortiche enormi; ortiche giganti. E ti facevano un male tremendo, che durava per un sacco di tempo dopo che ti eri punto. Riempivano un bel pezzo del prato dietro i negozi. Lì sembrava che non ci crescesse altro, solo ortiche colossali. Noi andavamo avanti menando dei colpi di qua e di là con bastoni e mazze da hockey. Poi, una volta tirate giù le ortiche, bisognava ridurle in poltiglia. Dalle piante maciullate usciva la linfa. Aprimmo diverse strade proprio in mezzo alle ortiche, una ciascuno, sempre a forza di bastoni e mazze. Tornammo a casa quando ormai tutti i sentieri tracciati finivano in un unico punto, e attorno non si vedevano più ortiche. Le mazze erano verdi e io avevo due punture sulla faccia: mi ero tolto il passamontagna perché mi prudeva la testa. Stavo guardando le briciole. Papà mise la mano sulla lente d'ingrandimento, e io gliela lasciai prendere. Si studiò i peli dell'altra mano. “Chi te l'ha data?” domandò. “Tu.” “Già, è vero; te l'ho data io.” Me la restituì. “Bravo ometto.” Premette forte il pollice sul tavolo di cucina. “Chissà se riesci a vedere l'impronta?” Non capivo bene. “L'impronta digitale”, disse lui. “Il segno lasciato dal pollice. ” Mi spostai con la sedia verso papà, e avvicinai la lente al punto in cui aveva premuto il pollice. Scrutammo tutti e due il tavolo di là dal vetro. Tutto quello che riuscii a vedere furono le macchioline gialle e rosse del piano di formica, ingrandite. “Beh, trovato niente?” “No, papà.” “Allora vieni con me”; mi disse. Lo seguii in soggiorno. “Dove ve la filate, voi due, che la cena è pronta?” domandò mamma. “Torniamo subito”, disse papà. Mi posò una mano sulla spalla. Andammo alla finestra. “Sali qui su, che ti faccio vedere.” Avvicinò una sedia perché ci montassi sopra in piedi. Poi alzò le veneziane parlando con loro, sì proprio con loro: “Via di qua che l'anatra deve vedere il coniglietto”. Fermò il cordoncino delle veneziane e rimase così qualche secondo, per essere sicuro che restavano su. Poi premette il pollice sul vetro. Ci restò una macchia tutta linee e curve. “Adesso tu”, disse. Premetti il pollice sul vetro, forte. Papà mi tenne per evitare che cadessi dalla sedia. Guardai. “Sono uguali?” domandò, “La tua è più grande.” “E a parte questo?” Io non sapevo cosa rispondere, così stetti zitto. “Queste due impronte sono completamente diverse l'una dall'altra”, disse papà. “Nessuno al mondo ha le impronte digitali uguali a quelle di un altro. Non lo sapevi?” “No.” “Beh, adesso lo sai.” Pochi giorni dopo, in una nuova puntata, Napoleon Solo trovò alcune impronte digitali sulla sua borsa. Guardai papà. E lui: “Che cosa ti avevo detto?” Col fienile noi non c'entravamo. Non fummo mica noi a dargli fuoco. Era un fienile abbandonato. Quando la Spa comprò la fattoria di Donnelly, lui se ne comprò una nuova vicino a Swords. Ci traslocò con armi e bagagli, e si portò via tutto, tranne la vecchia casa, il fienile, e l'odore. Nei giorni di pioggia l'odore era veramente brutto. L'umidità faceva venire fuori il puzzo della cacca lasciata dai maiali per anni e anni. Il fienile era un capannone immenso, colorato
