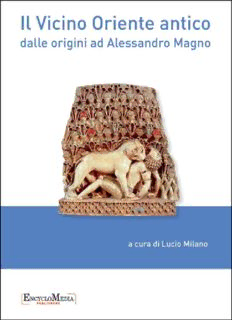
Il vicino Oriente antico dalle origini ad Alessandro Magno PDF
Preview Il vicino Oriente antico dalle origini ad Alessandro Magno
Sommario Il Vicino Oriente antico dalle origini ad Alessandro Magno Il Vicino Oriente antico dalle origini ad Alessandro Magno a cura di Lucio Milano testi di: Luisa Barbato (capitolo 7), Emanuele M. Ciampini (paragrafi 3.7; 4.6;5.6;6.7; 8.6.), Elena Devecchi (capitolo 5), Nicla De Zorzi (capitolo 4), Gian Maria Di Nocera (capitoli 1 e 2), Michael Jursa (capitolo 8), Giancarlo Lacerenza (capitolo 6), Massimo Maiocchi (capitolo 3). Direzione editoriale Danco Singer Coordinamento editoriale Margherita Marcheselli Redazione Rossana Di Fazio Segreteria di redazione Alice Vedovati Impaginazione Simona Golinelli Disegni e carte Daniela Blandino Progetto e copertina Susanne Gerhardt Questo volume è corredato da materiali multimediali disponibili on line; per ciascun capitolo è consultabile una gallery iconografica all'indirizzo www.encyclomedia.it, digitando il seguente codice: B000092012-010000101 Introduzione La storia del Vicino Oriente: come leggerla oggi di Lucio Milano Questo libro comincia e finisce con delle “rivoluzioni”. Tanto la cosiddetta “prima rivoluzione neolitica”, con cui si apre, quanto la conquista di Alessandro Magno, con cui si chiude, costituiscono momenti cruciali di una storia millenaria, che riconosciamo facilmente come “nostra”: è infatti la storia delle prime esperienze agricole, della nascita delle città e della stratificazione sociale, dell’organizzazione e dello sfruttamento della forza lavoro, dei commerci su vasta scala, delle guerre e della formazione degli imperi. Le vicende si snodano lungo un periodo di oltre diecimila anni, in una parte del mondo – il Vicino Oriente – che si estende dall’altopiano iranico fino al Mediterraneo e dal Mar Nero fino al Golfo Persico, includendo la valle del Nilo e quelle del Tigri e dell’Eufrate. Perché affrontare un arco di tempo così lungo e perché includere l’Egitto, che di solito è scorporato dalle sintesi di storia orientale? Su questo è il caso di spendere qualche parola, perché si tratta di una scelta di tipo sostanziale. Cominciamo dai limiti cronologici: sia per quello superiore, sia per quello inferiore, si tratta ovviamente di limiti convenzionali, che però vogliono mettere in evidenza due aspetti. Il primo è che ben poco si capirebbe dei fenomeni che possono considerarsi originali e costitutivi delle formazioni socio-economiche documentate nel Vicino Oriente senza affrontare la problematica relativa alle fasi protostoriche, precedenti (e talvolta contemporanee) all’introduzione della scrittura. Si può dire, anzi, che nell’esperienza vicino-orientale la protostoria faccia irruzione a più riprese nella storia, riproponendo modelli di sviluppo tecnologico, di aggregazione sociale o di occupazione del territorio che le sono appunto caratteristici. Il secondo aspetto riguarda un’esplicita messa in guardia dal considerare la storia del Vicino Oriente come una sorta di antefatto agli sviluppi delle civiltà classiche: non più e non tanto in un’ottica evoluzionistica – stereotipo ormai superato anche nell’istruzione scolastica – ma nei termini, storiograficamente più digeribili, di un’eredità culturale che l’Oriente avrebbe trasmesso alla Grecia e successivamente a Roma (attraverso l’Egitto), estesa alle forme dell’ideologia, delle istituzioni e della storia del pensiero o della scienza. Non che le eredità non esistano (e in questo libro se ne parla di continuo), ma esse si dimostrano assai più produttive all’interno dello stesso mondo orientale che non, per esempio, nei confronti della Grecia di epoca classica ed ellenistica. Di qui la scelta di scendere nella trattazione fino al periodo dell’impero persiano e della conquista di Alessandro Magno: con l’intenzione di mostrare quanto sia importante valorizzare l’enorme quantità delle fonti epigrafiche locali (dalla Persia, dalla Babilonia, dall’Egitto) per contestualizzare in modo equilibrato il fenomeno complesso e multiforme dell’ellenismo. La storia del Vicino Oriente antico dovrebbe così cessare di essere considerata la storia di un prima, e diventare piuttosto la storia di un durante, che renda a noi più comprensibili, talvolta per la loro omogeneità, ma più spesso per la loro alterità, istituzioni, fenomeni e processi di sviluppo presenti nelle vaste aree di contatto. La modalità, intensità e continuità/discontinuità dei contatti tra le diverse realtà regionali che compongono il mosaico vicino-orientale è in effetti uno degli aspetti più problematici e affascinanti di questo mondo: un mondo che appare come fortemente integrato e altrettanto fortemente differenziato, sia in campo politico che religioso e culturale. Fondamentale polo di attrazione, specie nel secondo e nel primo millennio a.C., è certamente l’Egitto, che instaura rapporti di interscambio commerciale e di protettorato politico su larga parte dell’oriente mediterraneo, esercitando, di volta in volta, il ruolo di interlocutore o di grande potenza, al tempo stesso coinvolto e “distante” rispetto all’endemica conflittualità dei regni orientali. È comunque il commercio, sia esso promosso da imprese familiari o amministrato da istituzioni pubbliche, che è veicolo pressoché costante di circolazione, oltre che di beni, di tecnologia e di cultura. Fin dal quarto millennio questo commercio si indirizza su lunghe distanze, che mettono in rapporto tra loro la Mesopotamia e la Siria con l’altopiano iranico e la valle dell’Indo, la regione anatolica e il Caucaso, innestandosi su una fitta rete di itinerari di raggio regionale, che nel primo millennio arrivano a includere le aree desertiche della penisola arabica. Uno dei più considerevoli effetti dell’attività mercantile è la diffusione di strumenti di comunicazione che servono ad agevolare le procedure di scambio: non solo le conoscenze tecniche relative alle operazioni contabili, ma soprattutto la scrittura, che progressivamente diventa, a partire dagli inizi del terzo millennio, uno strumento efficacissimo di coagulo culturale. Quasi certamente inventata pochi secoli prima in una piccola zona intensamente urbanizzata della Mesopotamia meridionale, la scrittura cuneiforme viene utilizzata per i successivi duemila anni in tutto il Vicino Oriente, fino al momento in cui sarà progressivamente affiancata e infine sostituita da scritture alfabetiche. La complessità del sistema cuneiforme (un sistema misto di segni sillabici e logografici) e il suo uso esclusivo da parte degli scribi, che lo apprendevano studiando e copiando lessici e testi esemplari della tradizione letteraria sumerica e accadica, porta a una canonizzazione di questo materiale e poi a una sua ampia diffusione, superando barriere linguistiche, geografiche e culturali. Dalla Mesopotamia all’Armenia, dall’Elam alla Siria-Palestina, fino agli altopiani centrali dell’Anatolia, il Vicino Oriente acquisisce progressivamente familiarità con gli stessi modelli di espressione letteraria, benché ciascuna regione e ciascuna cultura sviluppi parallelamente proprie tradizioni nelle lingue locali. Questo processo conosce il suo apice intorno al XIV-XIII secolo a.C., quando anche in Egitto troviamo scribi in grado di utilizzare il cuneiforme babilonese per corrispondere con le cancellerie del tempo in lingua accadica, divenuta la lingua franca in tutto il Vicino Oriente. Nonostante i numerosi elementi di convergenze, attribuibili in primo luogo alla diffusione del cuneiforme, il mondo di cui ci stiamo occupando è tuttavia caratterizzato da disomogeneità e contrasti, che derivano in larga misura da una realtà geografica frammentata e che riguardano la tipologia del popolamento, delle strutture insediamentali e delle forme di aggregazione politica. Tutto ciò sembrerà ovvio a chi guardi un atlante storico o geografico del Vicino Oriente, ma lo è assai meno nel nostro immaginario, nella consuetudine delle nostre rappresentazioni ideologiche o mentali: perché ancor oggi questo territorio è visto dai più come uno spazio indifferenziato, dove dominano la steppa e il deserto e in cui l’unico elemento geograficamente rilevante è costituito dalla presenza dei grandi fiumi. In realtà sono proprio le caratteristiche di questi fiumi ad attirare l’attenzione sulle differenze. Guardiamo per esempio l’Eufrate: il suo corso si disegna sul territorio in modo tutt’altro che uniforme, con larghi meandri nella parte più meridionale dell’alluvio e con lunghi tratti, più o meno lineari, in cui falesie rocciose ne delimitano l’alveo, con la formazione di microambienti che presentano condizioni ecologiche molto specifiche, che condizionano il raggio di deposito dei sedimenti, la composizione dei suoli, il loro livello di salinità e quindi le possibilità di sfruttamento delle campagne. C’è poi la realtà di una serie di affluenti dalla portata abbastanza considerevole (non molti, ma significativi per le loro implicazioni storiche) e quello dei corsi d’acqua minori, sia perenni, sia stagionali, che ha molto condizionato il carattere dell’antropizzazione; e ci sono le profonde differenze climatiche, che interessano non solo le grandi aree, come il nord e il sud della regione mesopotamica, ma anche nicchie assai circoscritte, dove la presenza di rilievi, di acquitrini o di risorgive incide sulle possibilità di adattamento delle popolazioni, sui modi di vita e sulle scelte economiche. Questo complesso di problematiche geografiche non riguarda soltanto la Mesopotamia, ma investe, con conseguenze di volta in volta specifiche, le altre regioni del Vicino Oriente asiatico, come la Siria (suddivisa tra la fascia costiera e le zone interne, a carattere collinare o stepposo), la Palestina, l’Anatolia (con altipiani e poderose catene montane) e l’Arabia (prevalentemente desertica). Perché quest’insistenza sulla varietà del quadro regionale, sui chiaroscuri, sulle differenze? I motivi sono prevalentemente due: il primo è quello di avvertire il lettore sulla specificità dei fenomeni di carattere strutturale che caratterizzano le società del Vicino Oriente a livello regionale, dalle forme della produzione, a quelle del commercio e della politica; il secondo è quello di richiamare la sua attenzione sul ritmo dei processi, che sono profondamente connessi al rapporto con l’ambiente naturale e alle trasformazioni del paesaggio, che ne è la sua proiezione nella storia. Per queste società (in forma assai più appariscente e drammatica che per altre) il ritmo è segnato dai successi e dagli insuccessi nella capacità di controllare la produzione e il procacciamento delle risorse, in un ambiente che è quasi sempre strutturalmente a rischio: un rischio rappresentato – tanto per citare i fenomeni più macroscopici – dalla siccità o dall’impoverimento dei suoli provocato da un eccessivo sfruttamento; dal rapido degrado delle opere idrauliche e di canalizzazione, dove queste sono indispensabili all’agricoltura (si ricordi per esempio che le piene dell’Eufrate, a differenza del Nilo, avvengono al momento del raccolto); dalla necessità di importare materie prime (legname e metalli) da regioni lontane. Questa situazione provoca non solo ciclici fenomeni di ristagno o di crisi sotto il profilo economico, ma anche fenomeni di ristrutturazione del rapporto tra città e campagna, di riorganizzazione topografica degli insediamenti, di ridefinizione di funzioni amministrative e di equilibri politici. È un ritmo accelerato, nei due sensi dello sviluppo e della periodica involuzione, che diventa esso stesso elemento di sistema all’interno di processi storici che appaiono per altri versi dominati da un’apparente stabilità: con realtà cittadine che mantengono per secoli, nonostante cambino le forme dell’organizzazione politica e le forme di assoggettamento (con piccoli e grandi regni, stati di carattere regionale o sopraregionale, imperi centralizzati), le loro caratteristiche di autonomia, che sono pronte a far valere ogniqualvolta si presentino delle crepe nel potere centrale. Le cosiddette “città-stato” non perdono quasi mai le loro prerogative, mantengono un saldo rapporto con il loro retroterra rurale, ricostituiscono eserciti, continuano a combattersi, almeno fino a quando le grandi organizzazioni imperiali (nel primo millennio a.C.) non impongono una rifunzionalizzazione del loro ruolo all’interno dell’apparato statale. Quello della stabilità apparente è un utile paradigma che serve a sottolineare le molte eccezioni: la realtà non si ripropone mai identica e aspetti evolutivi di grande portata, di carattere socio-economico e istituzionale, si possono apprezzare a ogni tornante della storia del Vicino Oriente. Vi sono tuttavia fenomeni che fanno da contrappunto a questi cambiamenti con una significativa ricorrenza, quasi a rappresentare un’emblematica spia dell’emergere (o del ricomporsi) dei momenti di crisi. Il più noto di questi fenomeni è quello del nomadismo, che coincide con una delle più potenti immagini ideologiche che l’occidente abbia costruito a proposito dell’Oriente. A partire dal XIX secolo, quando si diffonde il gusto romantico per l’Oriente e per le sue antichità, quando Francia, Inghilterra, Stati Uniti e Germania cominciano a finanziare le grandi imprese archeologiche in Egitto e in Mesopotamia, la figura del beduino e la società nomadica diventano per il viaggiatore occidentale uno degli elementi di maggiore fascino e suggestione all’interno di quel mondo, fino a incarnarne in qualche modo l’essenza e il mistero. Per lungo tempo – fino a non molti decenni fa, per dire il vero – è prevalsa l’idea che il nomadismo costituisse una tappa evolutiva specifica nel modello di sviluppo delle società umane del Vicino Oriente, e che il processo di sedentarizzazione progressiva dei gruppi nomadici fosse unilineare. Agli inizi del secolo scorso, quando negli studi linguistici era molto in voga il problema delle “origini”, si era ritenuto di poter ricercare l’origine dei Semiti e l’area di irradiazione delle lingue semitiche nel deserto sudarabico, popolato da nomadi che si spostavano su lunghe distanze. Ma, a parte le critiche che possiamo rivolgere a quel modo di porre il problema (con una insufficiente attenzione, tra l’altro, alla differenza tra nomadismo pastorale e il pieno nomadismo, praticato nel Vicino Oriente solo dalla fine del secondo millennio a.C., dopo l’introduzione del cammello) non si disponeva ancora della grande massa di dati sul fenomeno del nomadismo fornite dagli archivi cuneiformi. Le ricostruzioni storiche del Vicino Oriente preclassico, specie per quanto riguarda gli aspetti sociali e istituzionali, avevano al centro il grande affresco letterario delle storie bibliche dei patriarchi, che non avrebbero potuto in alcun modo illuminare un dato oggi incontrovertibile: che cioè le più antiche attestazioni di genti di lingua semitica in epoca protodinastica, tra il 2600 e il 2400 a.C., sia in Mesopotamia, sia in Siria (da dove provengono gli archivi di Ebla), si situano in contesti compiutamente urbanizzati, dove non risulta nessuna presenza di un elemento nomade. Tra le molte fonti che hanno portato a ridefinire l’intera problematica, le più significative sono comunque quelle che provengono dalla città di Mari (l’odierna Tell Hariri), che significativamente non si trova in Arabia, ma vicino al corso dell’Eufrate, poco a nord del confine tra la Siria e l’Iraq. Qui sorgeva un grande insediamento urbano che nel XVIII secolo a.C. controllava un’area molto vasta, che comprendeva un’ampia fetta dell’alta Mesopotamia, tra la valle del fiume Khabur e il Tigri. I nomadi, i beduini ante litteram, sono qui una realtà onnipresente, in parte integrata nella società e nell’economia cittadina, in parte separata, con proprie tribù di appartenenza, proprie istituzioni e un proprio modo di vita. Sono pastori di greggi di caprovini (per i quali è più appropriata la definizione di seminomadi) che si muovono su estensioni limitate e su percorsi collaudati, che praticano una transumanza orizzontale, che li porta in primavera-estate ad abbeverare il bestiame sulle rive dell’Eufrate, dove gli agricoltori coltivano i propri campi. Hanno in qualche caso una propria organizzazione politica e militare, che si presenta come relativamente indipendente, fin quando il potere statale non provvede a imbrigliarla, e mantengono equilibri di convivenza, variabili nel tempo, con la popolazione sedentaria; ma la loro
