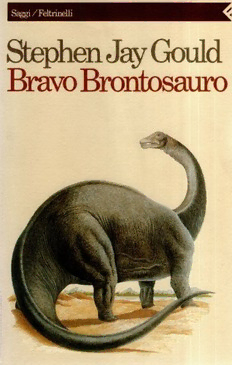
Bravo brontosauro PDF
Preview Bravo brontosauro
Prologo In Francia questo genere si chiama vulgarisation, ma le implicazioni del termine sono del tutto positive. In America lo chiamiamo popular (o pop) writing, e coloro che lo praticano vengono detti science writers, anche quando, come me, sono scienziati che cercano di rendere partecipi della ricchezza e bellezza del loro campo di studio persone che si occupano di altre cose. In Francia (e in tutt'Europa) la divulgazione figura fra le massime tradizioni dell'umanesimo e gode anche di un antico lignaggio: da san Francesco che parlava con gli animali a Galileo che decise di scrivere le sue due massime opere in volgare sotto forma di dialoghi, e non nel latino formale delle chiese e delle università. In America, per ragioni che non capisco (e che sono davvero perverse), le opere di divulgazione sono considerate con disprezzo, come forme di "adulterazione", di "semplificazione", di "desiderio di far colpo", come "fuochi d'artificio". Io non nego che queste espressioni possano applicarsi a molti autori; ma le opere mal riuscite e ispirate da basse motivazioni di profitto non possono invalidare un genere. I romanzi rosa non impediscono che l'amore possa essere un argomento valido per grandi romanzieri. Io deploro profondamente l'equazione di divulgazione con un discorso inferiore e con una forma di degradazione della verità, per due ragioni principali. Innanzitutto, un tale giudizio rischia di esporre a un giudizio negativo scienziati (specialmente scienziati giovani che non hanno una cattedra), che potrebbero volersi cimentare in questo genere aperto a un contatto con un grande pubblico. In secondo luogo, esso arreca un danno all'intelligenza di milioni di persone desiderose di qualche forma di stimolazione intellettuale che non sia impartita con paternalistica condiscendenza. Se gli autori di libri di scienza adottano un atteggiamento di altezzosa superiorità, non solo manifestano una forma di disprezzo verso il prossimo, ma contribuiscono a spegnere la luce dell'intelligenza. Il profano "acuto e intelligente" non è un mito. Queste persone sono milioni: forse sono poche in percentuale, ma il loro numero assoluto è elevato e la loro influenza è molto superiore alla loro proporzione nella popolazione. Io lo so nella forma più diretta possibile: attraverso le migliaia di lettere che ho ricevuto da profani nei vent'anni in cui ho scritto questi saggi, e in particolare dal gran numero di lettere di persone in età avanzata - ultraottantenni e anche ultranovantenni - i quali si sforzano ancora, con la massima intensità, di capire la ricchezza della natura e di accrescere la comprensione acquisita nel corso della loro lunga vita. Noi tutti dobbiamo impegnarci a recuperare la divulgazione della scienza come una tradizione intellettuale onorevole. Le regole sono semplici: non si deve mai rinunciare alla ricchezza intellettuale né si deve fare alcuna concessione all'ambiguità o all'ignoranza; si deve ovviamente evitare il più possibile l'uso del gergo scientifico sforzandosi però sempre di esprimere le idee nel modo più completo (qualsiasi complessità concettuale può essere espressa nel linguaggio comune). Oggi in America ci sono vari autori che si cimentano in questo tipo di pubblicazione, e chi è bravo ha successo. Il nostro compito primario consiste perciò nell'avere rapporti chiari col pubblico: dobbiamo impegnarci al massimo per far capire al pubblico che cosa siamo e che cosa non siamo, dobbiamo essere inflessibili nel richiamarci alla tradizione umanistica che risale fino a san Francesco e a Galileo e non alle ideologie anti-intellettualistiche che formano un'altra grande tradizione americana (le quali si appellano spesso a emozioni irrazionali che possono favorire rigurgiti di fascismo). La storia naturale umanistica si presenta in due distinte genealogie fondamentali: alla luce di quanto ho già detto, io le chiamo francescana e galileiana. Lo stile francescano è poesia della natura: un'esaltazione della bellezza organica attraverso una scelta corrispondente di parole e frasi. La sua genealogia va da san Francesco a Thoreau sul laghetto di Walden, a W. H. Hudson sulle colline inglesi, per arrivare, nella nostra generazione, fino a Loren Eiseley. L'atteggiamento mentale di Galileo trae invece piacere dagli enigmi intellettuali della natura e dalla ricerca della spiegazione e della comprensione. I galileiani non negano la bellezza viscerale, ma traggono un piacere maggiore dalla gioia della comprensione causale e dal suo potente tema dell'unificazione. 2 La genealogia galileiana (o razionalistica) ha radici molto più antiche del suo eponimo: essa va da Aristotele, che sezionava calamari, a Galileo che sconvolse il cielo, a Thomas H. Huxley che assegnò un nuovo posto all'uomo nella natura, a Peter B. Medawar (1915-1987), che ha denunciato le follie della nostra generazione. A me piace il modo di scrivere dei "francescani", ma mi considero un fervente, impenitente galileiano puro, per due ragioni principali. Innanzitutto, sarebbe per me imbarazzante cadere nel genere francescano. Il modo di scrivere poetico è il più pericoloso di tutti i generi perché gli insuccessi sono vistosi, costituendo di solito la forma più ridicola di prosa fiorita. Ognuno dovrebbe fare il suo mestiere, e i razionalisti dovrebbero attenersi al loro stile misurato. In secondo luogo, aveva ragione Wordsworth. Il bambino è il padre dell'uomo. Lo splendor in the grass della mia infanzia furono la confusione e gli edifici di New York. Le cose che mi hanno dato più gioia nella mia vita adulta sono state passeggiate in città, in mezzo a una sorprendente varietà di comportamenti umani e di architetture - dal Quirinale a Piazza Navona all'imbrunire, dalla New Town georgiana alla Old Town medievale di Edimburgo all'alba - più che escursioni nei boschi. Io non sono insensibile alla bellezza della natura, ma le mie gioie emotive si fondano particolarmente sulle opere improbabili e nondimeno talvolta mirabili di quel minuscolo e accidentale ramoscello dell'albero dell'evoluzione chiamato Homo sapiens. E fra queste opere non trovo niente di più nobile della storia dei nostri sforzi per capire la natura: un'entità maestosa di una tale vastità spaziale e temporale da non potersi curare di un piccolo ripensamento mammaliano associato a una curiosa invenzione dell'evoluzione, anche se, per la prima volta in circa quattro miliardi di anni di vita sulla terra, quest'invenzione ha prodotto la ricorsione, grazie alla quale un organismo ha la capacità di riflettere sulla sua origine e sulla sua evoluzione. Io amo perciò la natura primariamente per i rompicapo e i piaceri intellettuali che offre al primo organo capace di una tale curiosa contemplazione. I francescani possono ricercare un'unità poetica con la natura, ma anche noi razionalisti galileiani abbiamo un programma di unificazione: la natura ha prodotto la mente, e la mente le restituisce ora il favore cercando di comprendere l'entità che l'ha prodotta. Questa è la quinta raccolta di saggi editi nella mia rubrica "This View of Life" nella rivista "Natural History" (nel corso di diciotto anni ho pubblicato circa duecento saggi): i volumi precedenti sono, nell'ordine, Ever Since Darwin (Questa idea della vita), The Panda's Thumb (Il pollice del panda), Hen's Teeth and Horse's Toes (Quando i cavalli avevano le dita) e Flamingo's Smile (Il sorriso del fenicottero). I temi possono essere familiari al lettore (ma, confido, con un bel po' di novità), ma gli argomenti sono per lo più nuovi (e Dio non ha mai smesso di vivere nei particolari). Contro una possibile accusa di ridondanza, posso avanzare l'immodesta asserzione che questo volume è il migliore dei cinque. Io penso di aver fatto progressi come scrittore attraverso l'abitudine di scrivere un saggio al mese (a volte vorrei che tutte le copie di Ever Since Darwin si autodistruggessero), e in questo volume mi sono concesso più ampie facoltà di selezione e di scelta. (Mentre nella formazione dei volumi precedenti avevo raccolto la quasi totalità dei saggi pubblicati nella rivista in tre anni, lasciandone fuori solo un o due, in questo volume, che attinge da sei anni di attività, presento solo i pezzi migliori, o piuttosto quelli più in tema, lasciando fuori quasi il quaranta per cento della mia produzione.) Questi saggi, pur essendo incentrati sui temi sempiterni dell'evoluzione e delle innumerevoli, istruttive stranezze della natura, come le gigantesche uova del kiwi, registrano anche il distacco dei sei anni trascorsi dal quarto volume. Ho registrato anche, come dovevo, il nostro attuale stato di disagio e i nostri insuccessi: la situazione deplorevole dell'istruzione scientifica (considerata, com'è mia abitudine, non in modo astratto e tendenzioso, ma attraverso esempi e divagazioni che permettono di elevarsi quasi di soppiatto a generalità: fox-terrier e copiatura meccanica di libri di testo, o la possibilità di sfruttare la passione per i dinosauri a beneficio dell'istruzione) e un mesto epilogo sull'estinzione, avvenuta fra la pubblicazione su rivista e quella in questo libro, della rana che covava le uova nello stomaco. Devo però confessare che gli articoli che preferisco sono di solito quelli che trattano di 3 argomenti più immediati, e persino oscuri, specialmente quando la correzione di errori che li condannavano al ridicolo o all'oscurità permette oggi di riraccontare tali storie come pertinenti e istuttive. Così mi occupo della teoria di Abbott Thayer che i fenicotteri sono rossi per mimetizzarsi contro i predatori al tramonto del sole, e indago su quale sia stata la reale intenzione di Petrus Camper (criteri artistici) nel fissare una misura che sarebbe stata usata in seguito da scienziati razzisti, e tento di ricostruire la storia vera (e molto più interessante) che si cela dietro la stereotipa versione eroica della controversia fra Huxley e Wilberforce nel 1860. Alcuni hanno visto in me un enciclopedico, ma io insisto nel dire che non so far altro che il mio mestiere. Ammetto di fare uso di una vasta gamma di dettagli di vario genere, ma essi sono stati tutti scelti in funzione dell'obiettivo di illustrare gli argomenti usuali del mutamento evolutivo e della natura della storia. E spero che questo obiettivo limitato possa garantire coerenza e unità a una varietà dichiaratamente disparata di argomenti. La pallottola che colpì al sedere George Canning mi offre in realtà un modo per discutere quella stessa contingenza storica che governa l'evoluzione. Il racconto della nostalgia da me provata nell'assistere, a trent'anni di distanza dal mio conseguimento della maturità, al saggio di fine anno scolastico del coro della scuola superiore, vuol essere una formulazione generale (agrodolce, nella sua incapacità di risolvere una dicotomia fondamentale) sulla natura dell'eccellenza. Un altro sugli inizi del baseball esplora l'opposizione creazione-evoluzione come storie primarie per l'origine di ogni oggetto o istituzione. Un pensiero finale a francescani e galileiani alla luce delle nostre preoccupazioni ambientali, mentre un pianeta devastato si avvicina al millennio (nella cronologia umana, giacché la natura, contando in miliardi di anni, può solo ridacchiare). I francescani partecipano della gloria della natura per comunione diretta; eppure la natura è sommamente indifferente a noi e alle nostre sofferenze. Forse la sua vera gloria sta proprio in questa indifferenza, in questa maestà di una durata che si è estesa su miliardi di anni senza alcun corso predeterminato (prima che noi facessimo la nostra tardiva apparizione). Una quartina di Omar Khayyam colse questa verità fondamentale (anche se egli avrebbe dovuto descrivere il suo albergo orientale, la sua metafora per la Terra, come grandioso anziché come frusto): Tu pensa come, in questo frusto caravanserraglio Le cui porte si aprono e chiudono ogni giorno e ogni notte, Sultano dopo sultano, con tutta la sua pompa Attese il suo tempo prescritto, e poi se ne andò via. La vera bellezza della natura è la sua grandezza; essa non esiste né per noi né a causa nostra, e possiede un potere di sopravvivenza che i nostri arsenali non possono minacciare (mentre noi possiamo facilmente distruggere le nostre meschine esistenze). Quell'hybris che fu la causa principale dei nostri guai, e che gli ambientalisti cercano a tutti i costi di evitare, fino a includere questa finalità nella definizione del loro (dovrei dire del "nostro) movimento, torna spesso a insinuarsi in una forma inattesa (e perciò potenzialmente pericolosa) in due princìpi spesso avanzati dai movimenti "verdi": 1) che noi viviamo su un pianeta fragile, soggetto a essere distrutto in permanenza dalle malefatte dell'uomo; 2) che gli esseri umani dovrebbero erigersi a salvaguardia di questo fragile ambiente così minacciato per salvare il nostro pianeta. Ma non siamo certo così potenti! (Leggi questa frase nel mio accento newyorkese come derisione del senso male inteso della nostra onnipotenza, e non come un'espressione letterale di desiderio.) Nonostante tutta la nostra eccellenza mentale e tecnologica, penso che non potremmo fare molto per far deragliare la storia della Terra in un senso permanente alla vera scala di tempo planetaria, che è quella di milioni di anni. Nulla che sia in nostro potere può avvicinarsi a condizioni e catastrofi che la Terra ha spesso subìto e superato. Il peggiore scenario di innalzamento globale della temperatura planetaria nei modelli dell'effetto serra fornisce una Terra considerevolmente meno calda di quanto essa sia stata in molte epoche prospere e felici nel passato preumano. La potenza dell'impatto di materiale extraterrestre che probabilmente innescò 4 l'estinzione in massa del tardo Cretacico è stata stimata 10000 volte maggiore di tutti i megaton che potrebbe fornire l'intero arsenale nucleare oggi accumulato sulla Terra. E questa estinzione, che spazzò via il 50 per cento circa delle specie marine, fu trascurabile rispetto alla grandissima estinzione del Permiano, che circa 225 milioni di anni fa potrebbe aver cancellato dalla faccia della Terra fino al 95 per cento delle specie esistenti. Eppure la Terra si riprese da questi urti terribili, e l'evoluzione produsse alcuni interessanti novità (consideriamo solo le potenzialità del dominio dei mammiferi, compreso l'emergere dell'uomo, dopo l'eliminazione dei dinosauri). Ma il recupero e una nuova stabilizzazione hanno luogo su scale di tempo planetarie, non umane, ossia nell'arco di milioni di anni dopo l'evento perturbatore. A questa scala noi non possiamo fare alcun danno; il pianeta si prenderà cura di se stesso, nonostante la nostra meschina follia. Ma tale scala di tempo, anche se è naturale per la storia planetaria, non è commisurata alla nostra legittima preoccupazione campanilistica per la nostra specie e per le configurazioni attuali del pianeta che rendono possibile la nostra esistenza. In questi istanti planetari - i nostri millenni - noi abbiamo il potere di imporre grandissime sofferenze (sospetto che la catastrofe del Permiano sia stata decisamente sgradevole per le diciannove specie su venti che non sopravvissero). Noi non siamo certamente in grado di spazzar via i batteri (essi sono stati probabilmente gli organismi tipici sulla Terra fin dall'inizio, e probabilmente lo saranno fino a quando il sole concluderà la sua esistenza esplodendo); non penso che siamo in grado di provocare una grande devastazione permanente sugli insetti nella loro totalità (quale che sia il nostro potere di distruzione di popolazioni e specie su scala locale). Ma possiamo senza dubbio metter fine alla nostra fragile esistenza, e la nostra Terra ben protetta potrebbe tirare allora un metaforico sospiro di sollievo per il definitivo insuccesso di un esperimento interessante ma pericoloso di coscienza. L'innalzamento della temperatura su scala planetaria è preoccupante perché avrebbe come conseguenza la sommersíone delle nostre città (spesso costruite al livello del mare, specialmente nel caso di città portuali) e sconvolgerebbe la nostra agricoltura, con gravi danni per milioni di persone. La guerra nucleare è una suprema calamità per le sofferenze e la morte di miliardi di persone, e per le alterazioni genetiche che apporterebbe a milioni di persone nelle generazioni future. Il nostro pianeta non è affatto fragile alla sua scala di tempo e noi, modesti ultimi venuti, comparsi solo nell'ultimo microsecondo del nostro anno planetario, non possiamo erigerci a lungo termine a protettori di nulla. Eppure nessun movimento politico è più vitale e tempestivo dell'ambientalismo moderno, poiché noi dobbiamo salvare noi stessi (e le specie nostre vicine) dalle conseguenze immediate della nostra follia. Si parla molto di etica ambientalistica, e molte proposte incarnano l'astratta maestà di un imperativo categorico kantiano. Eppure io penso che abbiamo bisogno di qualcosa di molto più terra terra e di molto più pratico. Abbiamo bisogno di una versione del principio morale più utile e più antico di tutti: il precetto che è stato sviluppato in qualche forma da quasi tutte le culture poiché agisce, nel suo legittimo appello all'interesse egoistico, come una dottrina di stabilità fondata sul rispetto reciproco. Nessuno ha mai trovato niente di meglio di questa regola aurea. Se noi facciamo un patto del genere col nostro pianeta, impegnandoci a trattare la Terra come vorremmo essere trattati noi stessi, essa potrebbe placarsi e consentirci di cavarcela in qualche modo. Un obiettivo così limitato potrebbe sembrare a qualche lettore cinico o miope. Ricordiamoci però che, per un biologo evoluzionistico, la persistenza è la ricompensa unica. E il potere intellettuale umano, per ragioni che non hanno alcuna connessione con la sua origine evoluzionistica, ha la più dannata capacità di scoprire le cose più affascinanti, e di pensare le idee più peculiari. Perché dunque non dovremmo far sì che questo interessante esperimento possa continuare, almeno per un altro secondo planetario o due? 5 Parte prima La storia nell'evoluzione 1. Il gluteo sinistro di George Canning e l'Origine delle specie So che connessione esiste fra Charles Darwin e Abraham Lincoln: essi decisero di venire al mondo nello stesso giorno, il 12 febbraio 1809, fornendo così alla smemorata umanità un utile espediente mnemonico per ordinare la storia. (Grazie anche a John Adams e a Thomas Jefferson per essere morti nello stesso importantissimo giorno, il 4 luglio 1826, esattamente nel cinquantesimo anniversario della nascita ufficiale della nazione americana.) Ma che connessione c'è fra Charles Darwin e Andrew Jackson? Che cosa può avere in comune un gentiluomo inglese che padroneggiava magistralmente le astrazioni della scienza con quella vecchia quercia di Jackson che inaugurò la leggenda (sfruttata in seguito da Lincoln) del campagnolo con poca istruzione formale che lotta fino ad arrivare alla Casa Bianca? (Jackson era nato nel 1767 sul confine occidentale delle due Caroline, ma in seguito mise su bottega nel territorio pionieristico del Tennessee.) Questa difficile domanda richiede una lunga sequenza di connessioni, caratterizzate più da associazioni curiose che da necessità logica. Ma facciamo un tentativo, articolato in nove passi semplici. 1) Andy Jackson, in conseguenza delle sue imprese militari nella sfortunata guerra del 1812 (la seconda guerra d'indipendenza americana), divenne una figura nazionale e infine - grazie alla fama così conquistata - un candidato alla presidenza. In un conflitto che fu considerevolmente avaro di buone notizie, Jackson arrecò molto conforto alla nostra nazione vincendo la battaglia di New Orleans (1815), l'unica importante vittoria terrestre americana dopo molte sconfitte e punti morti. Con l'aiuto del corsaro Jean Lafitte (che fu allora perdonato dal presidente Madison, ma che riprese ben presto il suo modo di vita illegale), l'8 gennaio 1815 Jackson inflisse una disfatta decisiva alle forze britanniche costringendole a ritirarsi dalla Louisiana. Spesso i cinici sottolineano, forse poco generosamente, che la vittoria di Jackson si verificò più di due settimane dopo la conclusione ufficiale della guerra, notizia di cui nessuno era al corrente in quella regione paludosa perché il trattato era stato firmato a Gand e allora le notizie non viaggiavano più rapidamente delle navi. 2) Quando stavamo per ritirarci dal Vietnam e per riconoscere (almeno in privato) che gli Stati Uniti avevano perso la guerra, alcuni fra i sostenitori di quell'impresa (io non ero fra loro) trassero conforto dal ricordo che, se si lasciava da parte l'ipocrita retorica patriottica, quella non era la nostra prima sconfitta militare. Le tradizioni politiche ci presentano la guerra del 1812 come un pareggio, ma in realtà quella fu una guerra persa da noi, almeno in relazione all'obiettivo più importante che si ponevano i falchi di allora: l'annessione, almeno parziale, del Canada. Riuscimmo però sia a conservare il territorio sia a salvare la faccia, un risultato importante per il futuro dell'America e un ingrediente cruciale per la crescente reputazione di Jackson. Washington, così umiliata solo pochi mesi prima, quando le truppe britanniche incendiarono la Casa Bianca e il Campidoglio, gioì per le notizie di due fatti, ricevute all'inizio del 1815 in ordine inverso a quello del loro accadimento: la vittoria di Jackson a New Orleans e le condizioni favorevoli del trattato di Gand, firmato il 24 dicembre 1814. 3) Il trattato di Gand ripristinò tutti i confini nazionali prebellici; noi potemmo quindi sostenere che non avevamo perso un centimetro di territorio, anche se l'espansione in Canada non era stata un obiettivo tanto nascosto dei fautori della guerra. Il trattato affidò a commissioni di arbitrato la risoluzione di altri punti in discussione fra Stati Uniti e Canada; tutte le restanti controversie - fra cui l'istituzione di confini non fortificati, l'eliminazione delle forze navali dai Grandi Laghi, e l'instaurazione del confine sul San Lorenzo - furono negoziate pacificamente nell'ambito di queste disposizioni. Thomas Boylston Adams, discendente di John Quincy Adams (che negoziò e firmò il trattato), ha scritto recentemente su quell'esemplare documento (nella sua 6
